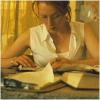LE COSE CHE HO IMPARATO NELLA VITA
di Paulo Coelho
Ecco alcune delle cose che ho imparato
nella vita:
Che non importa quanto sia buona una persona, ogni tanto ti ferirà.
E per questo, bisognerà che tu la perdoni.
Che ci vogliono anni per costruire la fiducia
e solo pochi secondi per distruggerla.
Che non dobbiamo cambiare amici,
se comprendiamo che gli amici cambiano.
Che le circostanze e l’ambiente hanno influenza su di noi,
ma noi siamo responsabili di noi stessi.
Che, o sarai tu a controllare i tuoi atti, o essi controlleranno te.
Ho imparato che gli eroi sono persone che hanno fatto ciò che era
necessario fare, affrontandone le conseguenze.
Che la pazienza richiede molta pratica.
Che ci sono persone che ci amano,
ma che semplicemente non sanno come dimostrarlo.
Che a volte, la persona che tu pensi ti sferrerà il colpo mortale
quando cadrai,
è invece una di quelle poche che ti aiuteranno a rialzarti.
Che solo perché qualcuno non ti ama come tu vorresti,
non significa che non ti ami con tutto se stesso.
Che non si deve mai dire a un bambino che i sogni sono sciocchezze:
sarebbe una tragedia se lo credesse.
Che non sempre è sufficiente essere perdonato da qualcuno.
Nella maggior parte dei casi sei tu a dover perdonare te stesso.
Che non importa in quanti pezzi il tuo cuore si è spezzato;
il mondo non si ferma, aspettando che tu lo ripari.
Forse Dio vuole che incontriamo un po’ di gente sbagliata
prima di incontrare quella giusta,
così quando finalmente la incontriamo,
sapremo come essere riconoscenti per quel regalo.
Quando la porta della felicità si chiude, un’altra si apre,
ma tante volte guardiamo così a lungo a quella chiusa,
che non vediamo quella che è stata aperta per noi.
La miglior specie d’amico è quel tipo con cui puoi stare seduto
in un portico e camminarci insieme, senza dire una parola, e quando vai
via senti come se fosse stata la miglior conversazione mai avuta.
È vero che non conosciamo ciò che abbiamo prima di perderlo,
ma è anche vero che non sappiamo ciò che ci è mancato
prima che arrivi.
Ci vuole solo un minuto per offendere qualcuno, un’ora per piacergli,
e un giorno per amarlo, ma ci vuole una vita per dimenticarlo.
Non cercare le apparenze, possono ingannare.
Non cercare la salute, anche quella può affievolirsi.
Cerca qualcuno che ti faccia sorridere
perché ci vuole solo un sorriso
per far sembrare brillante una giornataccia.
Trova quello che fa sorridere il tuo cuore.
Ci sono momenti nella vita
in cui qualcuno ti manca così tanto
che vorresti proprio tirarlo fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero!
Sogna ciò che ti va; vai dove vuoi; sii ciò che vuoi essere,
perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose
che vuoi fare.
Puoi avere abbastanza felicità da renderti dolce,
difficoltà a sufficienza da renderti forte,
dolore abbastanza da renderti umano,
speranza sufficiente a renderti felice.
Mettiti sempre nei panni degli altri.
Se ti senti stretto, probabilmente anche loro si sentono così.
Le più felici delle persone, non necessariamente hanno il meglio
di ogni cosa; soltanto traggono il meglio da ogni cosa che capita sul loro
cammino.
La felicità è ingannevole per quelli che piangono, quelli
che fanno male, quelli che hanno provato, solo così possono apprezzare
l’importanza delle persone che hanno toccato le loro vite.
Il miglior futuro è basato sul passato dimenticato, non puoi andare
bene nella vita prima di lasciare andare i tuoi fallimenti passati e i tuoi
dolori.
Quando sei nato, stavi piangendo e tutti intorno a te sorridevano. Vivi
la tua vita in modo che quando morirai, tu sia l’unico a sorridere
e ognuno intorno a te a piangere.
Manda questo messaggio a coloro che significano qualcosa per te, a quelli
che hanno toccato la tua vita in un modo o nell’altro, a quelli che
ti fanno sorridere quando veramente ne hai bisogno, a quelli che ti fanno
vedere il lato bello delle cose quando sei proprio giù, a quelli
cui vuoi far sapere che apprezzi la loro amicizia.
Se non lo fai, non ti preoccupare, non ti accadrà niente di male,
perderai solo l’opportunità di rallegrare la giornata di qualcuno
con questo messaggio.
ETICA
DEI COMPORTAMENTI,
LEGALITA’
E COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
FATTORI RILEVANTI
DI CONVENIENZA ECONOMICA
di Paolo Pantano
John M. Hartwick (1) sostiene che “per mantenere intatto il capitale
sociale ed ambientale, o se proviamo a sostituire i valori umani soppressi,
le risorse esaurite o i beni degradati con uno specifico ammontare d’investimento
di rendite di risorse aggregate, abbiamo la possibilità di preservare
alle generazioni future l’opzione di non stare peggio della generazione
che l’ha preceduta.”
Ciò risponde ad un’etica che dovrebbe essere sufficiente a far
sì che il genere umano adotti tutte le precauzioni per prevenire,
nel miglior modo possibile, i danni all’ambiente sociale e fisico per
non disperdere la quantità ereditata di risorse naturali. Persino
Adam Smith (2), il più importante sostenitore dell’interesse
personale come molla dell’economia, nella sua Teoria dei sentimenti
morali afferma che “ l’uomo dovrebbe considerare se stesso non
come qualcosa di separato e staccato, ma come un cittadino del mondo, un
membro della vasta comunità della natura ed all’interesse di
questa grande comunità egli dovrebbe sempre esser lieto che si sacrifichi
il suo piccolo interesse personale “ (pag.92). La base delle argomentazioni
del saggio Etica ed Economia del premio Nobel 1998 per l’economia Amartya
Sen (3) risiede nel concetto che “ l’economia può essere
resa più produttiva prestando maggiore e più esplicita attenzione
alle considerazioni di natura etica che informano il comportamento umano;
come, d'altronde, lo studio dell’etica può, a sua volta, beneficiare
da un più stretto contatto con l’economia. Il comportamento
mosso dall’interesse personale, in economia, ha ostacolato l’analisi
di relazioni molto significative, come, d'altronde, un comportamento collettivo
egoista diventa antieconomico per l’intera comunità. Ad esempio,
infatti, a causa dello sfruttamento massiccio, da parte delle nazioni industrializzate,
delle risorse naturali non rinnovabili, si va verso l’esaurimento di
alcune di esse e quindi diventa sempre più costoso estrarre energia
da fonti sempre meno sfruttabili, pertanto i costi per la dissipazione d’energia
e per il degrado ambientale si sommano ai costi sociali. L’impoverimento,
il sottosviluppo, la fame, le malattie creano profondi disagi, ribellioni,
crisi sociali ed esistenziali, crescita della criminalità e conseguenti
spese per fronteggiare il malessere e reprimere i reati conseguenti. Investire,
invece, nella prevenzione e nell’educazione alla legalità è
conveniente proprio dal punto di vista economico poiché lo sviluppo
migliore è possibile dove esiste la stabilità e dove vi è
sicurezza per gli operatori finanziari. Questi hanno più propensione
ad investire proprio dove le istituzioni sono più salde e dove vi
è maggiore impermeabilità nei confronti delle organizzazioni
criminali. Come per la salute è ormai assodato che è conveniente
investire nella prevenzione, così è per l’ambiente ed
anche per la legalità. Vi sono studi sistemici che dimostrano che
le spese sostenute per la prevenzione fanno risparmiare le comunità.”
Come sostiene, d’altronde, Joseph E. Stiglitz (4) (premio Nobel 2001
per l’economia) nel saggio In un mondo imperfetto: “Le cattive
politiche economiche sono causa di rivolte sociali e politiche, vi è
fuga di capitali, si rompe l’ordine sociale e, di fatto, l’economia
della nazione si allontana ancora dalla possibile ripresa.”
Come afferma Jeremy Rifkin (5), lo stesso, possiamo dire, avviene per le
risorse culturali. Anche queste rischiano di essere sfruttate oltre ogni
limite e di venire, perciò, depauperate, proprio come accadde nell’era
industriale alle risorse naturali. Sostiene Rifkin che “bisogna trovare
un modo per preservare e stimolare la diversità delle culture, cioè
la linfa vitale della civiltà, e questo soprattutto oggi poiché
siamo in un’economia di reti globali; ciò sarà una delle
questioni politiche prioritarie del nuovo secolo.”
Le persone creano comunità, costruiscono elaborati codici di comportamento,
trasmettono significati e valori condivisi e costruiscono rapporti di fiducia
in forma di capitale sociale. Solo se la fiducia e le relazioni sociali
corrette sono ben sviluppate, gli individui si dedicano al commercio. Se
ne deduce che la sfera economica è sempre stata derivata, e dipendente,
da quella culturale. Questo perché la cultura è la sorgente
da cui provengono le norme di comportamento condivise. Sono tali norme che,
a loro volta, creano un ambiente affidabile, dove commercio e scambi possono
avere luogo. Quando la sfera economica comincia a divorare la sfera culturale
le fondamenta sociali che hanno reso possibili ed incentivato le relazioni
rischiano di essere distrutte. Ripristinare un equilibrio adeguato fra il
dominio della cultura e quello dell’economia sarà, probabilmente,
un imperativo categorico per salvare il capitale culturale, evitare l’omologazione
e l’appiattimento culturale da un lato e la mancanza di stabilità
economica, dall’altro, con gravi deficit sociali ed istituzionali.
Un’economia responsabile ed un’etica di salvaguardia delle stabilità
e della tutela del capitale culturale oltre che creare un’identità
precisa, creano un circolo virtuoso di rating (affidabilità) tra
le istituzioni e la società e tra le nazioni stesse. Da un reciproco
riconoscimento nasce la fiducia e la convenienza a stipulare contratti vantaggiosi,
ciò rappresenta il valore aggiunto nei rapporti economici e sociali.
Come per la biologia e l’economia vi è spesso un’analogia
tra i principi che regolano le due discipline, come la matematica si rivela
indispensabile modellatrice di forme molecolari complesse, come la Fisica,
ha unificato l’approccio al problema della diversità energetica
nei sistemi non-viventi (avvalendosi dei principi della Termodinamica),
così l’etica e l’economia, pertanto, sono costrette ad
interagire costantemente per ottenere risultati rilevanti e per guidare
i complessi progetti di sintesi richiesti dal nostro tempo. Lionel Robbins
(7), nel suo autorevole Saggio sulla natura e l’importanza della scienza
economica, - affermava: “ Non sembra logicamente possibile associare
i due studi (economia ed etica) in una forma qualsiasi che non sia una semplice
giustapposizione “. Questo assunto formulato negli anni Trenta è,
oggi, condiviso da autorevoli rappresentanti della comunità scientifica
ed in particolare dai premi Nobel per l’economia Tobin, Solow, Becker,
Amartya Sen e Stiglitz.
Vi è stato, negli ultimi tempi, un positivo processo di riunificazione
dei saperi, ciò ha comportato una migliore comprensione dei meccanismi
delle varie discipline al fine di ottenere comportamenti equilibrati e transazioni
reciprocamente vantaggiose e quindi economie di scala più convenienti,
ma anche percorsi di sviluppo sostenibili e di conseguenza più efficaci
per le complessive compatibilità del pianeta.
Bibliografia :
(1) John M. Hartwick – Non-renewable resources extraction programs
and markets (Fundamentals of pure and applied economics series ) October
1989
(2) Adam Smith – The Theory of Moral Sentimentes, edizione riveduta,
ristampato in D.D. Raphael e A.L. Macfie (a cura di) Clarendon Press, Oxford
1975 - tr. it. parziale a cura di Antonino Negri, Il giudizio etico, Minerva
Italica, Bergamo 1970
(3) Amartya Sen – “Etica ed Economia “ Edizioni Laterza,
Bari terza edizione 2001
(4) Joseph E. Stiglitz – “ In un mondo imperfetto “, Donzelli
Editore, Roma 2001
(5) Jeremy Rifkin – “ L’era dell’accesso “ Oscar
Mondatori, Milano 2001
(6) Lionel Robbins – “ Saggio sulla natura e l’importanza
della scienza economica “ tr. It. A cura di Pasquale Jannaccone, UTET,
Torino 1953
F. E. ALBI, da Grimaldi (CS), Italia, ha conseguito un Ph.D. in Lingue e Letterature Romanze presso l’Università di California a Berkeley. Fra i suoi scritti recenti, parzialmente pubblicati, sono Pebbles in the Sand e Wilding in the Morn. Sighs and Songs of Aztlán, First Anthology of Chicano Literatur, Peregrinando (novelle) e una monografia su Salvatore di Giacomo sono fra i suoi primi lavori.
per saperne di più...
NATALE... IN AMERICA
di F. E. Albi
Spigolando sull’approssimarsi delle natalizie, tornerebbe
più romantico (e forse meno attendibile!) affidarsi alla magia del
ricordo e della reminiscenza. Ma la realtà del momento fa prevalere
associazioni insolite a riflessioni tradizionali. Capita così di
abbinare il ciclo natalizio a quello elettorale, ambo connessi all’ingranaggio
economico, e quindi essenzialmente perenni in America. Le campagne elettorali
ricominciano con l’annunzio dei risultati dell’ultimo suffragio,
ed il mercanteggiare natalizio si rinnova non appena svenduti gli ultimi
saldi. Si chiude un occhio, e vien di cavillare sulla scarsa equivalenza
del “Merry” e del “Buon”: il primo suggerisce la giovialità
esuberante d’un pancione incappucciato, in tenuta rosso/bianca e stivali
neri, ormai simbolo di commercio; il secondo sembra richiamare valori spirituali,
e segnalare la penuria d’uomini di buona volontà. Odio, guerra,
fame, pestilenza, cupidigia! Ordigni a bersaglio garantito, battaglie notturne,
al fresco, con truppe vaccinate, in tenuta climatizzata e maschera antitutto.
Visioni apocalittiche. Cabala o Bibbia in mano, si predica l’imminente
compimento di profezie antitetiche: l’arrivo del Messia, per gli ebrei
ortodossi, e la Seconda Venuta di Cristo per i protestanti. Fra chi non
è dotato di spirito profetico, Babbo Natale è emblematico
più di banchetti che non della mangiatoia. Siamo un po’ tutti
condizionati all’insegna del troppo: mangiare, bere, e spendere, spesso
anche quello che non si possiede. Si riconosce, al tempo, l’altruismo
di tanta brava gente che preferisce celebrare il Natale, un anno dopo l’altro,
a servizio della comunità, provvedendo ai bisogni di chi nulla tiene,
lavorando in cucine pubbliche, e servendo ai poveri ed ai senzatetto sostanziosi
pasti a base di tacchino al forno e torta di zucca. Meals on Wheels (Pasti
su ruote) si occupa della distribuzione a domicilio per ammalati o individui
che non si possono muovere. Sarà un modo di far penitenza per un
“Christmas” ridotto a sinonimo d’affari. Alcune industrie
si sorreggono esclusivamente sulla gestione della Natività, mentre
gran parte delle altre conta sugli introiti natalizi – che variano
dal 20 all’80% del totale annuo – per mandare avanti la baracca.
Fattore economico a parte, Natale è festa universale, che ognuno
celebra secondo i propri atavici costumi, quasi indistruttibili in fondo
al crogiolo. Gente di tutte le razze, proveniente da ogni parte del mondo,
vive in America. A New York si parlano ben 154 idiomi distinti. V’è
enorme ricchezza in tanta differenza, quasi a suggerire che la vita, benché
sempre un miracolo, è anche un accidente. Se cromosomi, ambiente
ed esperienza formano l’individuo, il caso (o la regola del caos) ne
determina il sesso, la razza, l’aspetto fisico, il quoziente d’intelligenza,
la salute, e persino l’orientamento religioso e la dieta. La libertà
di religione invita alla proliferazione di denominazioni diverse: in America,
se ne annoverano intorno a 1500! Si suol dire che chi non è allergico
ai fornelli tende a rivelare in cucina il proprio patrimonio ancestrale.
Si calcola che Gesù nasce in marzo o aprile, due o tre anni prima
dell’era che definisce. Il 25 dicembre è data arbitraria, scelta
fra l’altro perché in prossimità del solstizio invernale,
periodo dei Saturnalia romani e d’altri riti pagani. Agli effetti pratici
e spirituali, nulla si toglie alla solennità della ricorrenza. Certamente
non a caso, in data più recente – 1966 – Maulana Karenga,
attivista americano, istituendo il festival africano dei primi frutti –
Kwanzaa – decide di collocarlo nel periodo che va dal 26 dicembre al
primo gennaio. Il rito, redatto in swahili, è un impasto di principi
etnici in veste sacro-profana, fondati sull’etica universale. Le sette
candele del mishumaa si accendono, una ogni giorno, per rappresentare unità,
autodecisione, lavoro e responsabilità collettivi, cooperazione economica,
proposito, creatività e fede.
In seno alla Chiesa Cattolica, la festa della Natività ha origine
nel 336. In Inghilterra, Christes maesse o Christmas, festival di Cristo,
risale al 1050. Xmas, la cui X sta per crocifissione e per la lettera greca
chi di Kristos, rimonta al 1300. Sin dall’inizio, una varietà
di riti nordici si confondono con quelli cristiani. Lunga è la tradizione
del mistletoe (vischio), simbolo di vita e fertilità, nonché
di pace e salute. Sacra a Freya, dea norvegese dell’amore, la lorantacea
sempreverde si appende in un posto prominente della casa, e protegge tuttora
chi, durante le feste, si scambia un bacio sotto la pianta parassita. Tanta
mescolanza di riti sacro-profani per magnificare il Natale non riscosse
il beneplacito della Riforma; più tardi, nel XVII secolo, i Puritani
finirono per bandirne ogni festività in Inghilterra e Nord America,
dove la ricorrenza soleva indurre a giochi d’azzardo e generosa indulgenza
alle orge.
I regali solevano limitarsi a piccole somme in danaro, che i ricchi donavano
ai poveri, ed i padroni ai servi. In cambio, i servi offrivano un limone.
Prima della rivoluzione industriale, e quindi dello sviluppo della classe
media e d’una certa agiatezza, non esisteva lo scambio di regali in
famiglia o fra amici e parenti. Il Thanksgiving o Giorno del ringraziamento,
che pellegrini e pellirosse solevano dapprima celebrare in agosto, venne
eventualmente spostato per designare l’inizio ufficiale delle festività
natalizie. A petizione dei mercanti, il presidente Roosevelt, nel 1937,
anticipò il Thanksgiving d’una settimana, per dar loro più
agio di smerciare la roba. I dissensi sindacali che il settembre scorso
portarono al blocco del traffico marittimo sul Pacifico spinsero la Casa
Bianca ad intervenire per evitare che le spedizioni non arrivassero in tempo
utile.
Fra le consuetudini più comuni, quella dell’albero e di Babbo
Natale, ambo di origine europea, fanno concorrenza al Bimbo Redentore. Il
primo, anch’esso simbolo pagano di fertilità, fu introdotto
in America da immigranti germanici nel secolo XVII. La leggenda lo fa rimontare
ad una passeggiata di Lutero, in una notte di Vigilia, in una foresta di
abeti. Estasiato dalla bellezza della natura, il monaco si portò
un albero a casa, e lo decorò. Nel 1841, il principe Alberto di Germania
ne regalò uno alla consorte, Vittoria d’Inghilterra. Quella
di Santa Claus, nelle sue molteplici varianti, è una leggenda che
risale alla prima cristianità. Incorporando una varietà di
riti pagani, Befana inclusa, Santa Claus, in abito da vescovo, galoppa per
il cielo in groppa ad un cavallo bianco, per distribuire regali ai bambini
buoni. Lo gnomo che a volte lo segue – Black Peter – punisce quelli
cattivi. Il personaggio germanico, Christkindl, che si commemorava il 6
dicembre, ha generato Kriss Kringle nei paesi di lingua inglese. Il Santa
Claus americano proviene dall’olandese Sinter Claas, “importato”
nel 17esimo secolo. A cominciare dal 1773, appaiono svariate versioni in
racconti e poesie. Fra tanta confusione di riti e miti, Paolo VI depose
il santo dal calendario ufficiale nel 1969. La prima cartolina augurale,
di John Calcott, è del 1843. A partire dal 1875, la consuetudine
si popolarizzò man mano con il perfezionamento della litografia.
Dovuto all’eterogeneità del popolo americano e delle concentrazioni
etniche in svariate parti dell’unione, le tradizioni natalizie risalgono
al paese d'origine dell'immigrante. In alcune comunità di prevalenza
scandinava, si onora Santa Lucia, martire del secolo IV. In zone d’ascendenza
germanica, sono comuni i putzes o presepi primitivi. Nella Louisiana, lungo
le sponde del Mississipì, i Cajun, Acadi franco-canadesi originari
della Nova Scozia, accendono falò affinché Père Nöel
trovi più facilmente la strada di casa loro. In Terranova, Canada,
ha scarso successo il mummering, di origine britannica: coppie in maschera,
o in abiti del sesso opposto, cercano di non farsi conoscere dagli amici
che visitano, per finire tutti festeggiando con bevande e dolciumi. Fra
le moltitudini messicane sono numerose le posadas o rappresentazioni drammatiche
simili a quelle svolte in Assisi, al tempo del Santo: Maria e Giuseppe bussano
invano da porta a porta cercando alloggio, fino a quando qualcuno non li
ospita per far festa insieme. I piccoli mandano messaggi a Gesù Bambino
(ed a Quetzalcoatl, dio azteca!) con richieste di regali. Babbo Natale domina
ovunque: nel solito costume, suona (a paga minima!) un campanello davanti
ai supermercati per invogliare la gente a deporre spiccioli nella pentola
rossa appesa al tripode della Salvation Army. Dentro i negozi, Santa posa
con i bimbi, e riceve confidenze sulle loro predilezioni. Abita al Polo
Nord, dove innumerevoli gnomi allestiscono tutte le spedizioni da recapitare
la notte di Natale, via aerea, con slitta trainata da cervi che volano senz’ali.
La pubblicità generale contribuisce al parossismo: luci, decorazioni,
parate, film tradizionali, balletti. Si rispolverano vecchie melodie. Raramente
capita di ascoltare un motivo religioso come Tu scendi dalle stelle, ma
di solito è Rudolph, the red nose (e simili) che tiene banco. Fra
le melodie, di gran lunga la più rinomata è White Christmas.
Dettata nel 1941 da Irving Berlin, ebreo-americano d’origine russa,
fu lanciata da Bing Crosby in piena guerra, nel 1942, e continua ad avere
un successo fenomenale, come inno alla nostalgia. Non si fa allusione alla
Natività.
Molti fra noi non sanno dov’è Betlemme. Un recente sondaggio,
della CBS, non può non sbalordire: due su tre vogliono la guerra,
ma uno su tre non sa dove sia l’Iraq (che spesso diventa Airaq!). Mentre
Galileo continua a trasmettere dati da distanze difficilmente immaginabili,
l’uno su sei, con o senza lanterna, non riesce a scovare l’America
sul mappamondo. Con Sharon e Netanyahu a sentinella della Grotta, e con
Saddam e Bush a modello di compassione, rincuora sapere che non si muove
foglia che Dio non voglia. Per la gente di poca fede, vige la consapevolezza
che, ad ogni istante, indipendentemente dalla volontà dell’individuo,
nel caotico ordine dell’universo, tutto è sempre come deve essere.
Buon Natale!
Un caldo insolito e un soleil de nuit, per usare il titolo felice di un libro di versi di Prévert, accarezzano le giornate parigine di metà febbraio. Persino un quotidiano titola in piena prima pagina “L’estate d’inverno a Parigi”.
Al Quai de Malaquais, tanto caro a Sciascia che vi frequentava le librerie antiquarie, les bouquinistes, sul lungosenna, imperturbabili come sempre, osservano i passanti, offrono ascolto ai curiosi, suggeriscono gli acquisti di libri, stampe, riviste. Notre Dame si erge maestosa nell’Ile, quasi a fare da cuore pulsante del centro della ville lumière. A lato, sempre sulla rive gauche, al 37 di rue de la Bûcherie la libreria Shakespeare and Company è immarcescibile. Non si capisce se la facciata è come la foto di tanti anni fa, oppure è la foto che riproduce intatta la facciata della libreria ora come allora. Nello spiazzale antistante ampi scatoloni contengono libri usati, alla rinfusa, offerti al pubblico a prezzi stracciati.
La porta d’ingresso è aperta; mi accade di strisciarla appena: scricchiola e mi fa venire addosso i libri allocati alla maniera della libreria di Ciccio Urso.
Li raccolgo e non senza fatica li ripongo ai loro posti di attesa.
È ancora là dietro il tavolinetto, seduto sulla sedia, George Whitman. Ancora come tanti anni fa, quando gli consegnai il primo volumetto di poesie Miraggi e lui si affrettò a chiamare un ragazzo con una cinepresa per farmi un’intervista.
“Voi siete italiano e poeta”, mi aveva detto allora, vedendomi osservare gli scaffali che da terra al soffitto contengono libri in larga parte di lingua inglese.
“Come avete fatto a capirlo?” avevo chiesto.
“Italiano, da come siete vestito”.
“E poeta?”
“Sono vecchio…” aveva esclamato, portando l’indice della mano destra sulla palpebra inferiore di un occhio.
Ora è ancora nelle stesse condizioni o quasi, con una più acuita sordità. Comunque è meglio vestito. Al posto delle calze con grossi buchi e pantaloni stracciati indossa un paio di calzoni in velluto con calze in cotone e un maglione privo di buchi ma pieno di macchie.
Gli chiedo se ha ricevuto il volumetto Datteri verdi, che porta una poesia sulla libreria.
“Quando l’avete inviato?”, mi chiede.
“Alcuni anni fa”, rispondo.
“No, no, non ricordo di averlo ricevuto; per noi è molto importante una poesia o uno scritto sulla libreria”.
Mi invita a un rendez-vous per il dì seguente alle ore 16, al piano superiore della libreria, per un salotto letterario. Accetto.
Mostro a mia figlia Cetty la libreria.
Una ripida scaletta in legno conduce al piano rialzato.
Anche lì libri ovunque e anche due lettini, un tavolo, quattro sedie e una vecchia macchina da scrivere Remington, che gli ospiti possono utilizzare: c’è un ragazzo di colore, studente della Sorbona, che sta dattiloscrivendo una tesina. Un frigorifero come quelli di cui ho ricordo da bambino, un lavello in acciaio, un cucinino… Cetty osserva e commenta sbalordita.
Alle 16,30 del giorno appresso mi presento in libreria. Il vecchio, vedendomi fra gli avventori, mi fa cenno con la mano.
Prega un signore di scattarci una foto con la mia macchina fotografica, poi mi apre il portone accanto, verde, e m’invita a salire al primo piano. Nell’ingresso c’è tanta posta per terra e una bicicletta appoggiata sotto la buca delle lettere. Una larga scala mi conduce al piano superiore. La stanza, che ha la finestra che sporge su Notre Dame, è stracolma di libri; ci sono anche un tavolo, tre sedie e due sofà. Talune carpette contengono scritti sulla libreria, foto e interviste, tutto materiale d’archivio.
Una quindicina di strani personaggi sostano chi seduto, chi sdraiato, chi in piedi; alcuni sorseggiano un po’ di tè preparato nel cucinino, in un recipiente di rame e versato in bicchieri di plastica del tipo usa e getta, deformati dal troppo uso.
Le lingue che sento parlare sono prevalentemente inglese e tedesco, ma mi accorgo anche di una coppia di giapponesi. Tutta gente con in mano un libro, una rivista o che affronta un argomento letterario.
A loro confronto Whitman, che non brilla certo per eleganza, sembra alla moda.
Mi sento a disagio, ma prima l’indifferenza, poi la tiepida cordialità dei presenti mi induce a restare e a recitare la parte della comparsa o se si vuole, di un voyeur in quello strano salotto letterario. Ognuno avrà avuto le proprie buone ragioni per interloquire con gli altri: ho la vaga impressione di trovarmi in uno di quei locali dove, al tempo degli hippies, i figli dei fiori, si discuteva di amore e non di guerra.
Il tramonto s’approssima. Scendo giù, mi avvicino a Whitman e, ringraziandolo, gli comunico che gli manderò una fotocopia della poesia e la foto scattata prima.
Mi stringe forte la mano, dicendomi ad alta voce “Molte grazie, signore…”. Mi reimmergo nell’aria di Parigi. Senza voltarmi, comincio a percorrere il lungosenna, incrocio un via vai di gente, ma non la vedo: ripenso a quell’uomo canuto, con le palpebre rosse, un solo dente nell’arcata gengivaria inferiore, un maglione sporco, ma con un cuore generoso e pulito.
 Giovanni
Stella
Giovanni
Stella
Per RADIO TRE!!!
Interveniamo tempestivamente,
affinché non taccia una voce bella, preziosa, coraggiosa.
Una voce che è stata e potrebbe ancora essere la nostra.
di Cristina Tambacopoulos
L'altro giorno ho acceso la radio, sintonizzandomi sulle solite frequenze: Radiotre. Radio intelligente che da tempo ascolto, ammiro, difendo come idea, perché m'informa e mi forma, mi racconta, mi istruisce, mi rilassa e mi diverte senza involgarirmi, rivolgendosi al mio intelletto, senza mai trascurare le emozioni che per me contano parimenti - anzi, me ne insegna di nuove; un'isola piccola, ma felice, in un mare ultimamente infelicissimo dal punto di vista culturale. Radio che soddisfa la mia curiosità più sana, promuove il mio amore per il bello, la mia insofferenza per il brutto, il volgare; un esercizio costante che acuisce anche il mio senso critico e rinforza la mia coscienza civica e civile, facendomi sentire cittadina fiera di una società e di un mondo che ama riflettere ed essere rispettato per questo, che rifiuta il fast food della mente - precotto ed indigesto - che i vari mass media ci servono quotidianamente a iosa, con rare eccezioni (Radiotre lo è stata per anni) che confermano solo la triste regola della cultura del consumo di un mondo inteso diversamente: un mondo di mercanti e di infinite mercanzie che non escludono nemmeno gli affetti, dove vige la logica delle cifre (offerta che s'adegua alla domanda) e dell'immagine.
Radiotre, finora isola felice del sapere. Radiotre che amo e che ascolto, ma non riconosco più. Qualcosa non è più come prima, qualcosa non quadra, qualcosa se ne va della sua identità, un'insolita tendenza a ...giocherellare più del solito, come per paura che qualcuno si possa annoiare. Eppure... i nomi, le voci dei presentatori sono ancora (ma fino a quando?) gli stessi. Solo che - strano, ma vero - mi sorprendo ad annoiarmi. Perché ho la sensazione che la mia radio non parla più, ma solo "dice delle cose"? Perché sono tentata di cambiare frequenza? Una veloce passeggiata (per l'ora tarda) nel web offre una parziale risposta al mio quesito: infatti, da qualche mese sono in atto dei cambiamenti che hanno portato alla fusione di Radiotre con Radiodue, sotto la direzione di Sergio Valzania, direttore di Radiodue fino allo scorso aprile. Ora vedo pienamente confermata la notizia che mi era arrivata per mail un po' di tempo fa sotto il titolo preoccupante "Addio ai programmi di Radiotre". Vorrei ringraziare l'amica che l'ha avuta prima di me e molto sollecita me l'ha fatta avere subito. Nel contempo, non posso non preoccuparmi: cosa detta questa decisione, chi l'ha votata e per chi e a quali "miglioramenti" finora insospettati da noi - massa amorfa di ascoltatori ignoranti?! - porterà mai la cancellazione di validissime trasmissioni di cultura (anche etnica), quali Buddha Bar, Grammelot o L'Arcimboldo (un'ora piena, dedicata all'Arte) e che cosa le sostituirà? Chissà... staremo a vedere.
Naturalmente, un'idea me la sono già fatta; non serve certo essere dei grandi esperti per vedere l'evidente, basta e avanza il senso comune. Quello su cui - ovviamente! - il Signor Valzania conta meno, quando da un lato afferma che Radiotre è una radio "costruita principalmente per il popolo della sinistra" e dall'altro, propone delle "scelte musicali moderne e più propositive" (banalmente tradotto in musica un po' "per tutti i gusti"), per risanare "una radio che negli ultimi tempi quasi ricordava ...Radio Maria"! Non ci credete? Cercatevi l'articolo sull'argomento in questione, apparso ultimamente su La Stampa . Provare per credere. Oltre che la comprensibile frustrazione, perdonatemi poi la confusione. Non si capisce se c'è da vergognarsi di più (e quindi risanarsi) per essere del popolo di sinistra o ascoltatore di Radiotre o intellettuale o infine ...amante di Radio Maria! Il signor direttore ce lo dovrà spiegare.
Per chi si è sentito preoccupato e offeso da tanta volgarità, lascio alcuni indirizzi dove è possibile far ascoltare la propria voce. Se davvero teniamo alla Cultura con C maiuscola, dobbiamo dimostrare di meritarcela. Fermiamo con decisione un ulteriore passo verso lo svilimento. Interveniamo tempestivamente, affinché non taccia una voce bella, preziosa, coraggiosa. Una voce che è stata e potrebbe ancora essere la nostra.
Con arrabbiata preoccupazione,
 Cristina
Cristina
La Repubblica:
fax 06 49822923 e-mail: larepubblica@repubblica.it
Il Corriere della Sera:
fax 02 62827579 e-mail: lettere@rcs.it
l'Unità:
fax 06 69646217-69646219 e-mail: cultura@unita.it
l'Espresso:
fax 06 8845167-8550246 e-mail: espresso@espressoedit.it
Diario:
e-mail: direttore@diario.it
|
Domenica 11 dicembre 2005 alle ore 18.00 nei locali di Crisilio Castello ad Avola, Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla hanno presentato i volumi da loro curati: Stefano Pirandello, Tutto il teatro, Bompiani e Luigi e Stefano Pirandello, Nel tempo della lontananza, Ed. La Cantinella. Sebastiano Burgaretta è intervenuto col discorso che qui di seguito riportiamo. I
PIRANDELLO OLTRE LA MASCHERA
|
 La
vita o si vive o si scrive. Io non l’ho vissuta, se non scrivendola.
Questo è ciò che scrisse il 10 0ttobre 1921 Luigi
Pirandello a Ugo Ojetti. Questa confessione, che allora sarebbe
potuta apparire la spia di una certa civetteria intellettuale,
oggi si rivela per quella che veramente era, cioè il segno
di un disagio esistenziale personalmente vissuto e intimamente
sofferto, al di là dell’immagine che del grande drammaturgo
siciliano si è potuta sedimentare nella mente di lettori
e studiosi. La verità è che ci vendichiamo, scrivendo,
d’esser nati avrebbe poi scritto ai figli Pirandello. Lo
stesso concetto, del resto, è confermato in termini più
circostanziati in quella sorta di riflesso speculare che ne viene
dato dal figlio Stefano in una lettera al padre, del 10 giugno
1926, nella quale, cercando di incoraggiarlo, scrive testualmente:Io
vedo che sei sempre arrivato ad approfittarti di ogni sciagura,
di ogni contrarietà, per la tua arte – sei sempre
riuscito ad astrarle dalle determinazioni dei tuoi casi e a poterci
lavorare sopra. Tu hai sempre dominato te stesso e la tua sorte.
Se tu avessi avuto una sorte più facile, a che ti sarebbe
servito possedere tanta energia?[…] Essere infelice, come
tu sei, Papà mio, vale bene la pena di esserlo!(1).
La
vita o si vive o si scrive. Io non l’ho vissuta, se non scrivendola.
Questo è ciò che scrisse il 10 0ttobre 1921 Luigi
Pirandello a Ugo Ojetti. Questa confessione, che allora sarebbe
potuta apparire la spia di una certa civetteria intellettuale,
oggi si rivela per quella che veramente era, cioè il segno
di un disagio esistenziale personalmente vissuto e intimamente
sofferto, al di là dell’immagine che del grande drammaturgo
siciliano si è potuta sedimentare nella mente di lettori
e studiosi. La verità è che ci vendichiamo, scrivendo,
d’esser nati avrebbe poi scritto ai figli Pirandello. Lo
stesso concetto, del resto, è confermato in termini più
circostanziati in quella sorta di riflesso speculare che ne viene
dato dal figlio Stefano in una lettera al padre, del 10 giugno
1926, nella quale, cercando di incoraggiarlo, scrive testualmente:Io
vedo che sei sempre arrivato ad approfittarti di ogni sciagura,
di ogni contrarietà, per la tua arte – sei sempre
riuscito ad astrarle dalle determinazioni dei tuoi casi e a poterci
lavorare sopra. Tu hai sempre dominato te stesso e la tua sorte.
Se tu avessi avuto una sorte più facile, a che ti sarebbe
servito possedere tanta energia?[…] Essere infelice, come
tu sei, Papà mio, vale bene la pena di esserlo!(1). rimase
vicino al genitore – si sarebbe tentati di dire sotto il
genitore, in verità anche per le ambizioni letterarie del
figlio – fu Stefano, il figlio prigioniero, ben si può
dire, in tutti i sensi nell’arco della sua vita: fuori casa
negli anni bellici in Germania, dentro casa negli anni trascorsi
a collaborare con il padre in ogni incombenza comportata dal lavoro
e dagli impegni del grande drammaturgo; i due ebbero rapporti
intensi e non sempre facili, anzi tutt’altro, con la gente
di teatro, con i produttori cinematografici, con gli agenti editoriali,
con i capocomici, con gli stessi familiari etc..Gli fece da segretario
e da negro anche in determinati momenti di emergenza.
rimase
vicino al genitore – si sarebbe tentati di dire sotto il
genitore, in verità anche per le ambizioni letterarie del
figlio – fu Stefano, il figlio prigioniero, ben si può
dire, in tutti i sensi nell’arco della sua vita: fuori casa
negli anni bellici in Germania, dentro casa negli anni trascorsi
a collaborare con il padre in ogni incombenza comportata dal lavoro
e dagli impegni del grande drammaturgo; i due ebbero rapporti
intensi e non sempre facili, anzi tutt’altro, con la gente
di teatro, con i produttori cinematografici, con gli agenti editoriali,
con i capocomici, con gli stessi familiari etc..Gli fece da segretario
e da negro anche in determinati momenti di emergenza. La
salvezza, diciamo così, dell’equilibrio personale
di Stefano, messo a dura prova dal difficile carattere paterno,
oltre che dai mille problemi quotidiani e strutturali all’universo
dell’uomo e dell’artista Luigi Pirandello, risulta quasi
prodigiosa, e certamente ammirevole, tanto più, se si tiene
presente il dramma, tutto personale suo, di non vedersi riconosciute
le qualità di autore di teatro che indubbiamente ebbe.
Coraggioso, non soltanto traumatico, il suo ritiro dagli ambienti
teatrali dopo il fiasco registrato nel 1953 dalla messa in scena,
ad opera di Giorgio Strehler, di Sacrilegio massimo: sempre più
deluso, appartato, solitario – come scrive la Muscarà
– si chiudeva in un amaro silenzio, rinunciando a pubblicare
ma non a scrivere(2). E già molti anni prima, in una lettera
scritta da Berlino il 24 marzo 1930, Luigi aveva cercato di consolare
il figlio degli insuccessi teatrali, facendo appello agli affetti
familiari che a Stefano arridevano, cosa che non si poteva certo
dire del padre, cui per contro arrideva invece il successo teatrale:Tu
hai, Stenù mio, il gran conforto della tua bella famigliola,
con codesta gioia di Ninì e l’amore dei due maschietti
e la compagnia sicura, la divina “due-tudine”, come
dice il poeta Dehmel, con la tua Olinda. Se le cose del teatro
ti vanno ancora male, ti puoi in qualche modo consolare(3). Come
dire: a nessuno è dato di essere felice due volte in contemporanea;
non si può avere tutto. E ancora nella stessa lettera:Verrà
certo il tuo momento, perché scrivi belle cose…Ma
che puoi sperare dalle compagnie italiane, come sono ridotte?
Un lavoro come il tuo è fato per un pubblico,speciale preparato
ed educato in un teatro adatto. Il pubblico dei soliti teatri
non credo che possa sopportare tale spasimo d’umanità
La
salvezza, diciamo così, dell’equilibrio personale
di Stefano, messo a dura prova dal difficile carattere paterno,
oltre che dai mille problemi quotidiani e strutturali all’universo
dell’uomo e dell’artista Luigi Pirandello, risulta quasi
prodigiosa, e certamente ammirevole, tanto più, se si tiene
presente il dramma, tutto personale suo, di non vedersi riconosciute
le qualità di autore di teatro che indubbiamente ebbe.
Coraggioso, non soltanto traumatico, il suo ritiro dagli ambienti
teatrali dopo il fiasco registrato nel 1953 dalla messa in scena,
ad opera di Giorgio Strehler, di Sacrilegio massimo: sempre più
deluso, appartato, solitario – come scrive la Muscarà
– si chiudeva in un amaro silenzio, rinunciando a pubblicare
ma non a scrivere(2). E già molti anni prima, in una lettera
scritta da Berlino il 24 marzo 1930, Luigi aveva cercato di consolare
il figlio degli insuccessi teatrali, facendo appello agli affetti
familiari che a Stefano arridevano, cosa che non si poteva certo
dire del padre, cui per contro arrideva invece il successo teatrale:Tu
hai, Stenù mio, il gran conforto della tua bella famigliola,
con codesta gioia di Ninì e l’amore dei due maschietti
e la compagnia sicura, la divina “due-tudine”, come
dice il poeta Dehmel, con la tua Olinda. Se le cose del teatro
ti vanno ancora male, ti puoi in qualche modo consolare(3). Come
dire: a nessuno è dato di essere felice due volte in contemporanea;
non si può avere tutto. E ancora nella stessa lettera:Verrà
certo il tuo momento, perché scrivi belle cose…Ma
che puoi sperare dalle compagnie italiane, come sono ridotte?
Un lavoro come il tuo è fato per un pubblico,speciale preparato
ed educato in un teatro adatto. Il pubblico dei soliti teatri
non credo che possa sopportare tale spasimo d’umanità